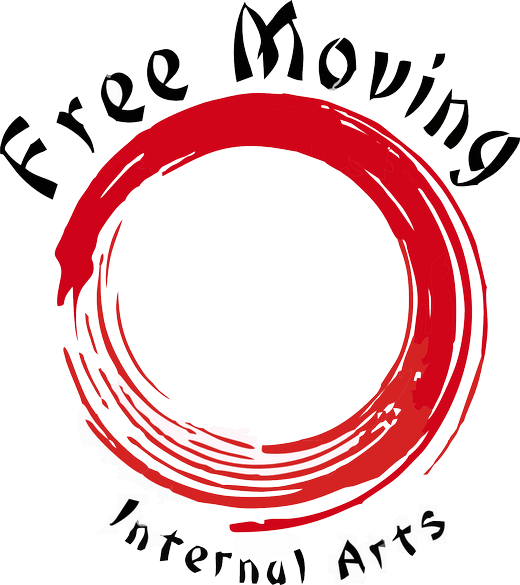110 Intervista fatta a Sifu Stefano Bernacchi
.
 Intervista fatta a Sifu Stefano Bernacchi
Intervista fatta a Sifu Stefano BernacchiL'argomento delle arti marziali interne è affascinante e complesso, come evidenziato nell'articolo.
Nell' articolo emerge il concetto di energia interna ( bioelettricità)che rappresenta una componente essenziale di discipline come il Dim Mak ( ovvero Hao Chuan, che oggi è conosciuto come Tai Chi Chuan YANG, ma che ha perso nel 95% dei casi tutta l' essenza), spesso descritto come un metodo avanzato e non semplicemente una tecnica isolata.
Secondo Bernacchi il Dim Mak, o Dian Xue, si basa su una profonda conoscenza dei meridiani del corpo umano e richiede un tipo specifico di allenamento che viene sviluppato soprattutto negli stili interni cinesi, come il Tai Chi Chuan e il Pa Kua. Egli sottolinea che molte scuole di Tai Chi Chuan di oggi si concentrano principalmente su pratiche come il Tui Shou, un esercizio creato tra la fine del XIX secolo e i primi anni del XX secolo. Questo tipo di esercizio non è pensato come un metodo di combattimento, ma come un allenamento per sviluppare la capacità di percepire il movimento dell'avversario tramite il contatto, un concetto noto come Ting Jing.
Il Dim Mak non è una tecnica ma un metodo avanzato marziale.
Una delle caratteristiche centrali del Dim Mak è la sua connessione con l'espressione esplosiva dell'energia, chiamata Fa Jing. Questo principio è fondamentale per far penetrare i colpi nei punti vitali dei meridiani.
Bernacchi fa notare che le radici di questo tipo di conoscenza si possono trovare in culture antiche, come quella cinese e indiana, dove furono condotti studi sul corpo umano che contribuirono allo sviluppo di questi sistemi di combattimento e guarigione.
Per apprendere il Dim Mak, Bernacchi evidenzia l'importanza di una solida conoscenza dell'anatomia umana e dei meridiani, oltre allo studio dei principi dell'agopuntura. Oggi esistono molti strumenti utili per chi vuole approfondire questi argomenti, tra cui libri, video e manichini che illustrano la posizione dei punti vitali. Tuttavia, è chiaro che l'apprendimento del Dim Mak non può avvenire solo attraverso la lettura di libri; è necessario un insegnante esperto e un gruppo di persone con cui praticare.
Alla base del Dim Mak c’è quello che viene definito Fa Jing.
Il Dim Mak è stato ideato da Chang San Feng con due amici agopuntori intorno al 1300, dopo sperimentazioni fatte su carcerati vivi, questo potrebbe scandalizzare oggi , ma nella Cina del 1300, come in Europa del resto in passato non era insolito un certo tipo di approccio.
Il Dim Mak è il metodo più avanzato del Tai Chi Chuan ma anche in altri metodi. Ricordatevi sempre che non ci sono arti marziali più evolute di altre, ma l’evoluzione è all’interno della stessa arte, dice Bernacchi.
Un aspetto interessante è la struttura gerarchica dei livelli di apprendimento nel Tai Chi Chuan. Secondo Bernacchi ci sono più livelli (almeno cinque) di esecuzione della forma Yang, che vanno dalla semplice memorizzazione della sequenza, al perfezionamento della respirazione e alla capacità di esprimere il Fa Jing in ogni tecnica. Ogni livello successivo richiede anni di pratica, e la progressione dipende dall'impegno nello studio e nell'allenamento delle tecniche interne.
All’inizio si imparano le basi che consiste nel memorizzare la sequenza dei movimenti e la struttura base. Avanzando si impara l’accumulo dell’energia e “smussare gli angoli”. Avanzando ancora si impara a gestire bene il respiro. Aumentando il livello si passa alla respirazione inversa, ai movimenti di apertura e chiusura e hai cambi Yin Yang. Poi si introduce il Fa Jing, la forma a scapola. Crescendo nella maestria il movimento diventa sempre più piccolo che non vuol dire però renderlo più piccolo , ma che è tutto il corpo che esegue il movimento e non sono più gli arti. “Non è il muoversi lentamente che fa di voi dei conoscitori del Tai Chi Chuan, anzi!”
Occorre una pratica costante di almeno cinque anni per raggiungere il terzo livello. Ovviamente un maestro serio e capace introduce parallelamente vari esercizi per far crescere l’allievo.
Questo concetto si applica anche ad altri stili interni, come il Pa Kua e lo Hsing-I. Nel Pa Kua, ad esempio, uno degli esercizi più importanti è il camminare in cerchio, che non solo migliora la coordinazione e l'equilibrio, ma allena anche le tecniche di calcio per la difesa personale. Gli "otto palmi" del Pa Kua sono un altro aspetto distintivo, riflettendo la filosofia dell'I Ching, il Libro dei Mutamenti. Tuttavia, inizialmente esistevano solo due palmi principali, che venivano allenati in modo intensivo, e solo in seguito ne furono sviluppati altri.
Normalmente in quelle scuole di Tai Chi Chuan Yang che si è allontanato dall’originale metodo, l’allenamento consiste nella pratica di un qualche Qi gong, l’esecuzione di forme, e al massimo un po’ di “tira e spingi” , delle leve o del Tui Shou. Esercizio quest’ultimo introdotto tra il XIX e il XX secolo. Non è un combattimento (questa idea va completamente scartata) ma un allenamento al Qi gong in coppia, dove si scambia energia, una forma di collaborazione per sviluppare delle abilità, come diventare più sensibili o quello di intuire il movimento fisico e mentale attraverso il contatto e il sistema nervoso. Ting Jing.
Bernacchi conclude sottolineando che, per ottenere un certo effetto Dim Mak, spesso si utilizzano combinazioni di colpi su più punti vitali in sequenza, colpendo con precisione e angolazione specifiche. Questi attacchi complessi richiedono anni di studio e pratica, e dimostrano quanto sia fondamentale il lavoro in coppia per comprendere e applicare correttamente le informazioni contenute nelle forme tradizionali.
Molto si è perso di questi metodi, perciò grande è la responsabilità di quei maestri che con umiltà, un duro lavoro e un profondo spirito di ricerca cercano in tutti i modi di farli sopravvivere.
In sintesi, l'articolo di Bernacchi mette in luce come le arti marziali interne cinesi, attraverso una combinazione di pratiche fisiche, mentali e spirituali, offrano un percorso unico per sviluppare l'energia interna, applicabile non solo al combattimento, ma anche alla cura di sé e degli altri.
Ilaria Valassina
.